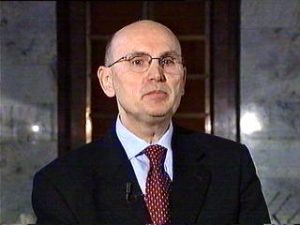Il dibattito tra Saraceno, Keynes e Schumpeter.
La scienza economica, nel suo inizio, si era occupata del comportamento ottimizzante dell’homo oeconomicus, della teoria dell’impresa, delle diverse forme dei mercato, dei costi di produzione, dell’utilizzazione ottimale delle risorse da parte del singolo individuo. Keynes sposta totalmente l’analisi sull’economia dei grandi aggregati: consumi, risparmi, investimenti, reddito nazionale. Egli afferma che tra i due tipi di analisi non esiste alcuna relazione.
Il pensiero keynesiano non si è diffuso subito, ma dopo la seconda guerra mondiale e, in modo particolare, a partire dalla fine degli anni cinquanta e negli anni sessanta del secolo scorso. Da questo periodo possiamo dire che gran parte degli economisti nati dopo la seconda guerra mondiale sono in larga parte keynesiani per l’analisi e per le politiche economiche.
E’ interessante notare che l’uscita della Teoria Generale nel 1936 non è stata accolta favorevolmente da gran parte degli economisti dell’epoca, nati tra le due guerre mondiali. E anche i maggiori economisti italiani non hanno fatto eccezione. Ne citiamo solo alcuni per brevità: Luigi Einaudi, Paolo Sylos Labini, Bresciani-Turroni, Marco Fanno e molti altri.
Luigi Einaudi era particolarmente critico rispetto al moltiplicatore keynesiano, per la sequenza risparmi e investimenti. Affermare che gli investimenti vengono prima dei risparmi era per Einaudi un’eresia. Per Einaudi i risparmi, frutto del comportamento virtuoso dei buoni padri di famiglia, devono necessariamente precedere gli investimenti.
Nel 1933 Einaudi scrisse un articolo polemico dal titolo “Il mio piano non è quello di Keynes”. Einaudi, come già accennato, si confronta con il moltiplicatore keynesiano del rapporto tra risparmi e investimenti che ne è alla base. Egli mostra incomprensione del concetto di moltiplicatore degli investimenti ed afferma che “senza lepre non si fanno i pasticci di lepre”.
Nel 1939, nella prefazione all’edizione francese della Teoria Generale, Keynes aveva ribadito l’erroneità di estendere al sistema economico nel suo complesso quelle relazioni che erano valide a livello disaggregato, sostenendo la diversità tra il comportamento dell’individuo nella microeconomia, per la quale ha significato parlare di rapporto tra disponibilità e consumo individuale e le leggi della macroeconomia per le quali il reddito nazionale è determinato dalla spesa. Ciò richiede naturalmente stabilità della struttura della domanda e dell’offerta globali, dei prezzi relativi e della dinamica dei settori produttivi.
Questa diversità dei due piani di analisi è ben presente in Einaudi il quale, come abbiamo già accennato, considera l’insieme degli atti individuali di rinuncia al consumo come il presupposto dell’adeguata formazione di risparmio, necessario al finanziamento della spesa per investimenti.
Poi la Teoria Generale non sembrava agli economisti italiani dei primi anni del novecento tanto generale perché nata sulla spinta di un evento straordinario come la grande crisi del 1929. E’ vero che la sfiducia innescata da tale crisi aveva fatto precipitare l’efficienza marginale del capitale per cui non era possibile immaginare tassi di interesse così bassi per sollevare per via endogena il reddito e l’occupazione, ma invocare per questo gli investimenti pubblici organizzati dallo Stato per risollevare la domanda con tutti gli effetti conseguenti sulle pubbliche finanze, sembrava troppo. E ciò perché non c’era accordo sulle cause della crisi perché essa poteva essere stata provocata da un eccesso di investimenti, come sosteneva Hayek, e non dal sottoconsumo come sosteneva Keynes.
Abbiamo pertanto due posizioni opposte: quella di Keynes come crisi da sottoconsumo e deficienza della domanda globale e quella di Hayek come crisi da sovrainvestimento. Anche il Fanno ha una posizione diversa da Keynes perché parla di punto critico della deflazione e sottolinea l’importanza dei cicli economici nelle economie stazionarie e nelle economie progressive.
La Teoria Generale di Keynes mette in ombra la figura dell’imprenditore e colloca al suo posto lo Stato che organizza direttamente gli investimenti, diventando fattore fondamentale dello sviluppo del reddito e dell’occupazione.
Viene messa in ombra in questo modo anche l’opera fondamentale di J. Schumpeter che vede il progresso scientifico e tecnico motore dello sviluppo economico. E’ fondamentale per Schumpeter la figura dell’imprenditore innovatore che innova i processi produttivi e i prodotti, va alla ricerca di nuovi mercati, introduce nuovi modelli organizzativi dell’impresa, avvia nuovi metodi di trasporto e di comunicazione. Il secondo pilastro schumperiano dello sviluppo è rappresentato dalle piccole e medie imprese che operano in un ambiente concorrenziale. Il terzo pilastro sono le banche che creano credito e consentono la trasformazione delle innovazioni in prodotti per il mercato. Successivamente Schumpeter darà più importanza alle grandi imprese e ai grandi monopoli trustificati, mettendo in evidenza il ruolo delle forme di mercato nei processi di sviluppo.
La dinamica settoriale è fondamentale per Schumpeter, mentre Keynes la ignora completamente. Nella dinamica economica vecchi settori muoiono e nascono quelli nuovi, vecchie imprese muoiono a lasciano lo spazio a imprese nuove, vecchie famiglie muoiono e nascono quelle nuove. E’ pertanto fondamentale l’offerta su cui insisterà molto Pasquale Saraceno per avviare meccanismi di sviluppo e di occupazione nel Mezzogiorno.
L’economista italiano P. Sylos Labini sostiene con forza la fecondità del pensiero schumpeteriano e compie analisi molto avanzate nel campo dell’oligopolio e del progresso tecnico. Le forme di mercato sono importanti ai fini dello sviluppo e dell’occupazione. Le forme monopolistiche consentono, a differenza della concorrenza, il controllo dei prezzi, il tasso di crescita, la dinamica degli utili e dell’autofinanziamento. Quest’ultimo consente alla grande impresa monopolista od oligopolista di finanziare con mezzi propri la maggior parte degli investimenti, indipendentemente dai flussi di credito delle banche e dalle politiche monetarie condotte dalla Banche Centrali. Le piccole imprese operano invece in prevalenza in contesti concorrenziali, senza possibilità di controllo dei prezzi, con minori utili e minore capacità di autofinanziamento. Il finanziamento degli investimenti dipende in larga parte dal credito bancario e dalle politiche monetarie e quindi le piccole e medie imprese sono molto più dipendenti dalle politiche monetarie della banche centrali.
Sylos Labini è l’economista italiano che più di tutti sostiene la necessità di un’integrazione tra micro e macroeconomia, superando i limiti del pensiero keynesiano dei prezzi fissi e della non considerazione delle forme di mercato, e dell’ottica di breve periodo.
Ma nell’attuale mondo che viviamo è più importante la microeconomia o la macroeconomia? La risposta a questa domanda porta naturalmente a sottolineare l’attualità o l’inattualità di Keynes e del pensiero keynesiano. Possiamo tuttavia dire senza ombra di dubbio che per capire le attuali dinamiche economiche mondiali è certamente più utile la microeconomia che la macroeconomia, come evidenziato dai grandi oligopoli delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La teoria neoclassica è in fondo il paradigma dominante nella teoria economica. Ma il paradigma neoclassico è refrattario alla teoria dello sviluppo, come sottolineato con forza da Pasquale Saraceno. Da qui il profondo senso di insoddisfazione da cui gli economisti contemporanei tentano di uscire con grande difficoltà perché attratti dalla bellezza formale dei modelli che non ci aiutano a capire a fondo quello che sta succedendo nel mondo di oggi. Si tratta essenzialmente di modelli dei grandi aggregati che non catturano tutte le modifiche che avvengono nei settori economici sotto l’impulso della velocità del progresso scientifico e tecnico. Da qui discende la fondamentale insufficienza delle politiche keynesiane del controllo della domanda aggregata per lo sviluppo del reddito e dell’occupazione, soprattutto in presenza di economie dualistiche come nel caso dell’Italia per il superamento delle quali sono necessarie politiche dell’offerta come ci ha insegnato Pasquale Saraceno.
Giovanni Scangatta
Professore di politica economica e monetaria all’Università di Roma “La Sapienza”